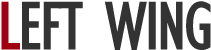Sulle pagine culturali del Financial Times sabato scorso Harry Eyres osservava che Stalin era decisamente più colto di George W. Bush o di Tony Blair. Testualmente: “Joseph Stalin was undoubtedly far more cultured in this sense than either Tony Blair or George W. Bush”. In this sense, cioè nel senso che alla parola cultured danno gli spagnoli. Poche righe sopra il giornalista ha infatti spiegato che in Spagna mai ha sentito attribuire la minima accezione negativa al termine culto, associandolo magari a snobismo o presunzione (“Non posso ricordare una sola persona che io abbia incontrato in Spagna per la quale essere culto era una cosa cattiva” annota con sconcerto).
Tra i libri preferiti da Blair compaiono Ivanhoe e Il signore degli anelli, insieme a qualche altro meno noto ma non più impegnativo volume, che il nostro commentatore giudica tutte ottime letture, ma certo più appropriate a un ragazzino di dodici anni che a un uomo di cinquanta. Lo stesso vale per le note preferenze del premier britannico per la musica pop. Quanto a Bush, non è chiaro se il duro regime di esercizi fisici che si impone, insieme agli obblighi connessi al suo mestiere, gli lasci tempo per la lettura. Ed ecco invece l’esempio di Stalin, che adorava Bulgakov (anche se questo, come noto, non evitò all’artista le attenzioni della censura e della polizia) e permetteva addirittura alla pianista Maria Yudina di suonare in pubblico, da cristiana devota qual era, esponendo orgogliosamente un crocifisso sul petto. Naturalmente, osserva il giornalista, è meglio essere governati da ignoranti democratici che da raffinati dittatori. Eppure.
Il resto dell’articolo è meno divertente e più banale. Ma in quell’eppure sta il punto. A George W. Bush non si dedica più che una fugace battuta finale. Il problema che sta a cuore al giornalista è chiaramente la perdita delle radici culturali europee. E’ l’idea che il New Labour, nonostante la sua veltroniana generosità nei confronti delle arti e degli artisti, sia corresponsabile della volgarizzazione della cultura nazionale. Di un abbassamento del livello intellettuale del discorso pubblico. E che un fenomeno analogo non sia limitato alla sola Gran Bretagna. Tanto da spingere Eyres a osservare che un uomo profondamente culto qual era Mitterrand – avido lettore dei classici della letteratura francese e in particolare della poesia – con la rara padronanza della lingua che lo contraddistingueva, mai si sarebbe spinto a definire racaille i ribelli delle banlieue (come invece ha fatto Nicolas Sarkozy, eccitando ulteriormente la rivolta). L’osservazione non potrebbe essere meno azzeccata, nel paese in cui il primo ministro Dominique de Villepin si diletta di poesia e ha dato alle stampe anche un corposo libro sui cento giorni di Napoleone, per fare un solo esempio.
La nutrita presenza di persone colte e coltivate nella politica francese non cambia la sostanza: se in Europa siamo davvero di fronte alla perdita delle radici culturali e alla conseguente crisi di identità, il centro del sisma è a Parigi. Non a caso, dopo il no alla costituzione europea e la rivolta delle banlieue, in Francia ora si sta discutendo accanitamente di una legge dello stato, votata dal partito di maggioranza, che contiene un passaggio in cui si loda apertamente la funzione civilizzatrice del colonialismo francese. E tutto questo nell’ambito di una surreale discussione sull’insegnamento della storia nelle scuole che ricorda assai da vicino analoghe polemiche italiane.
Marcello Pera naturalmente non avrebbe mai portato a esempio Stalin, ma nell’articolo del Financial Times c’è qualcosa di profondamente assonante con i nostri difensori delle radici cristiane. Per l’autorevole quotidiano della City di Londra, nostalgico del dittatore georgiano e del materialismo dialettico, ai politici democratici di oggi manca quella visione profonda delle cose che solo viene dalla conoscenza storica. Marcello Pera sottoscriverebbe subito, alla più che accettabile condizione che accanto alla conoscenza storica si inserisse un riferimento all’identità giudaico-cristiana. Ma se alla storia prestassero maggiore attenzione, entrambi i nostri cupi osservatori si renderebbero conto che è almeno dai tempi di Orazio che gli intellettuali lamentano i guasti della modernità: la perdita delle radici, la perdita di identità, la perdita di valori. E che i cristiani furono perseguitati dall’Impero romano esattamente per questo.
Naturalmente è preferibile essere governati da ignoranti democratici che da raffinati dittatori, scrive l’uno. Naturalmente è preferibile essere governati da democratici relativisti che da un supremo consiglio dei dottori della fede in nome della verità, direbbe – forse – l’altro.
Eppure (aggiungerebbero entrambi).