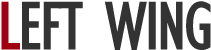Quando il 14 febbraio l’ex primo ministro sunnita Rafiq Hariri fu ucciso da un’autobomba a Beirut, la rivolta popolare contro la Siria che ne seguì fece parlare l’occidente di una “rivoluzione dei cedri”...
Assistendo all’agonia di Sharon – perlomeno del primo ministro non più in carica, se non dell’uomo – e alla partecipazione con cui viene seguita sia in Israele sia nelle cancellerie di tutto il mondo, ci si pone questa domanda: come è avvenuto che Ariel Sharon – l’uomo che l’ex primo ministro Menachem Begin non voleva nominare ministro della difesa perché temeva potesse “circondare l’ufficio del primo ministro con i carri armati”, l’uomo che dopo la debâcle del Libano nel 1982…
Tre anni fa, nella notte tra il 19 e il 20 marzo, la coalizione guidata dagli Stati Uniti invadeva l’Iraq di Saddam Hussein, spaccando a metà tra favorevoli e contrari l’amplissima coalizione internazionale che subito dopo l’11 settembre 2001 aveva guidato l’intervento in Afghanistan e suscitando in tutto il mondo – meno che negli Usa – proteste popolari di una tale ampiezza da far scrivere al New York Times che era scesa in campo l’altra vera superpotenza superstite: quella dell’opinione pubblica mondiale. L’intervento in Iraq è stato insomma talmente controverso e talmente significativo da porsi accanto, e forse sopravanzare, l’11 settembre 2001 come evento periodizzante dell’inizio di un mondo globale postmoderno e postwestfaliano…
Da quando è stato abbattuto Saddam Hussein, la sicurezza regionale in Medio Oriente ha sempre avuto solo tre attori di prima grandezza: Usa, Israele e Iran. Si tratta di un equilibrio dinamico, sempre soggetto a cambiamenti nei rapporti di potenza…
A cinque anni da quell’incredibile ed epocale 11 settembre 2001, tutti noi abbiamo visto la nostra stessa vita cambiare e gli spazi pubblici restringersi o addirittura chiudersi. Ciò ha significato un indebolirsi della politica. Il luogo in cui il processo è stato più evidente è quel Medio Oriente da dove tutto partì molti anni prima, con il primo jihad verso l’Afghanistan. Lo è non per una sorta di retribuzione divina, bensì perché vi è stato più concretamente l’errore dell’intervento Usa in Iraq che ha accresciuto le già grandi difficoltà della politica nella regione. Si è trattato infatti di un evento che ha profondamente cambiato il Medio Oriente. Ma non come si aspettava l’Amministrazione Usa…
Dopo avere disertato le elezioni costituenti del 30 gennaio e parzialmente anche il referendum confermativo della Costituzione del 15 ottobre, i sunniti iracheni…
Giovedì 10 novembre un terremoto politico ha colpito Tel Aviv. Contrariamente alle aspettative di tutti le primarie del partito laburista israeliano hanno designato non l’ottantaduenne presidente protempore (e vicepremier nel governo di coalizione con il Likud) Shimon Peres, bensì Amir Peretz. Dei 65mila membri del partito che hanno preso parte alle primarie, infatti, il 42,4 per cento ha votato per Peretz, il 39,9 per Peres e il 16,8 per Beniamin Ben-Eliezer. La sorpresa è stata generale…
La questione oggi sul tavolo tra Israele e Palestina è se il ritiro unilaterale da Gaza sia solo il primo passo o se invece rimarrà un episodio isolato: “Gaza first” o “Gaza only”. La prima opzione significa che dopo Gaza Israele affronterà finalmente l’annosa questione delle colonie nei territori occupati in Cisgiordania; scegliere la seconda, invece, vorrà dire inevitabilmente creare in Cisgiordania una serie di bantustan palestinesi senza continuità territoriale, facendo così naufragare la possibilità…
Martedì 1 novembre il governo israeliano ha approvato un piano a suo modo rivoluzionario quanto il ritiro unilaterale da Gaza: ha chiesto all’Unione europea di fornire osservatori comunitari e personale specializzato per ispezionare i viaggiatori…
In Turchia si parla molto in questi giorni di una piccola notizia, insignificante per il resto del mondo: l’entrata in attività del primo pozzo petrolifero del Kurdistan iracheno. Una notizia che ha fatto divampare un incendio politico in Iraq e in Turchia. Per quanto riguarda l’Iraq, l’apertura del pozzo di Zakho, a venti chilometri dal confine con la Turchia, ha fatto zampillare con ancor maggiore virulenza la contesa per i proventi del petrolio…
Con il voto dei poliziotti e dei servizi di sicurezza, anticipato di qualche giorno per assicurare un loro pieno impegno nel regolare svolgimento delle elezioni quattro giorni dopo, i palestinesi hanno cominciato a votare…
Nel rischioso e ancora instabile dopoguerra libanese, la comunità internazionale adesso ha la possibilità di lavorare per cominciare a sciogliere molti dei nodi che soffocano il Medio Oriente, e che si sono venuti aggrovigliando con l’intervento angloamericano in Iraq. Per deficit di potenza, se non per scelta analitica e intellettuale, è infatti di nuovo in voga l’azione politica multilaterale, il concerto delle nazioni fuori e dentro gli organismi internazionali…